venerdì 23 marzo 2012
Poesia senza titolo
la melodia del suono più dolce
il vino più inebriante;
un immagine in bianco e nero
un'idea romantica
un ideale utopico.
Vorrei morire dopo aver suonato la canzone perfetta
la musica del mondo intero,
dopo aver cantato la poesia di tutti gli uomini.
Vorrei salire sulla montagna più alta
e gridare forte il mio amore.
Facce anonime senza nome
e senza storia.
E dopo tutto questo
vorrei morire.
La morte è la fine di quel film
che noi tutti chiamiamo vita,
dove se non è successo almeno un fatto
che meriti di essere ricordato,
allora l'attesa della morte sarà angosciante.
Vecchi e stupidi sotto le coperte di un letto malconcio,
in attesa di essere portati via.
Amedeo 'Vincent' Di Luna
sabato 17 marzo 2012
L'artificio Intellettuale
Francis
La lingua savant
Il rapporto che ho con la lingua è estetico, nel senso che trovo alcune parole o combinazioni di parole particolarmente belle e stimolanti. A volte leggo e rileggo una certa frase per le sensazioni che suscita in me. I sostantivi sono le mie parole preferite, perché sono le più semplici da visualizzare. Ho un ottima memoria visiva, e quando leggo una parola o una frase chiudo gli occhi e la visualizzo, dopodiché la ricordo perfettamente. Vi sono alcuni aspetti della lingua che trovo più problematici di altri. Le parole astratte sono molto più difficili da capire per me e ho un'immagine mentale di ognuna che mi aiuta ad afferrarne il significato. Ad esempio la parola “complessità” mi fa pensare ad una treccia di capelli con varie ciocche che formano un insieme composito. Allo stesso modo la parola “trionfo” evoca nella mia mente l'immagine di un grande trofeo dorato. Se sento parlare del “trionfo elettorale” di un politico, immagino quest'ultimo che solleva un trofeo sopra la testa come l'allenatore di una squadra di calcio. Alcune strutture sintattiche sono particolarmente complicate da analizzare per me, come: "non è inesperto in queste cose", dove le due negative (non e in) si annullano. Da bambino trovavo decisamente oscure le espressione idiomatiche. Quando sentivo che qualcuno aveva del fegato pensavo: ma non lo abbiamo tutti il fegato? […]
Da bambino accarezzai per anni l'idea di creare una lingua tutta mia per alleviare la mia solitudine e godere del piacere che provavo giocando con le parole. A volte, quando sentivo un'emozione particolarmente forte o mi trovavo di fronte a qualcosa di molto bello, nella mia mente si formava spontaneamente una parola nuova che non avevo idea da dove venisse. Allo stesso modo, trovavo spesso al lingua dei miei coetanei stridente e confusa. Venivo preso in giro perché usavo frasi lunghe, accurate ed eccessivamente formali e, quando ricorrevo a uno dei miei neologismi per esprimere ciò che sentivo, non venivo quasi mai capito. I miei genitori mi dicevano di smettere di "parlare di modo strano". Malgrado ciò, continuai a sognare che un giorno avrei parlato una lingua tutta mia che mi avrebbe aiuto ad esprimermi compiutamente e che non sarei stato preso in giro o rimproverato per il fatto di utilizzarla. Quando smisi di studiare mi resi conto che avevo il tempo di perseguire seriamente quell'idea. Scrivevo le parole che mi venivano in mente e sperimentavo diverse possibilità di pronuncia e di costruzione delle frasi. Battezzai la mia lingua "manti" dal finlandese “manty” che significa pino. Molte delle parole del manti sono di origine baltica e scandinava cosi come i pini sono originari dell'emisfero boreale e sono particolarmente diffusi in Scandinavia e nella regione baltica. Ma c'è un altro motivo per la scelta di questo nome: i pini crescono spesso insieme in grandi gruppi e simboleggiano l'amicizia e la collettività.
Il manti è provvisto di una sua grammatica e di un vocabolario composto da oltre mille parole, ed è in continuo divenire. Ha attratto l'interesse di numerosi studiosi del linguaggio che ritengono possa contribuire a far luce sulle capacità linguistiche che condivido con altri savant.
Uno degli aspetti che amo di più di giocare con la lingua è la creazione di nuove parole e idee. Nel manti cerco di fare in modo che le parole riflettano i rapporti fra cose diverse: “hamma” (dente) e “hemme” (formica, un insetto che morde) e “rat” (cavo) e “ratio” (radio). Alcune parole hanno significati multipli e correlati: “puhu”, ad esempio, può significare vento, respiro e spirito.
Il manti possiede molte parole composite: “puhekello” (telefono, letteralmente “campana parlante”), “ilmalav” (aeroplano, letteralmente “nave dell'aria”) “tontoo” (musica, letteralmente “arte del tono”) e “ratalo” (parlamento, letteralmente “luogo di discussione”) .
Quanto ai termini astratti, vi sono diversi modi per esprimerli. Uno è la creazione di un composto: il concetto di ritardo si traduce con “kellokult” (letteralmente “debito di orologio”). Un altro metodo consiste nell'utilizzare coppie di parole, come avviene in estone, lingua appartenente al ceppo ugro-finnico. L'equivalente del manti del termine latticini è “pimat kermat” (latte e panne); quello di calzature è invece “koet saapat" (scarpe e stivali).
Sebbene il manti sia molto diverso dall'inglese, possiede molti termini facilmente riconoscibili dagli anglofoni come “nekka” (collo), “kuppi” (tazza) “purassi” (portafogli) “noot” (notte) e “pepi” (bimbo). Il manti è l'espressione tangibile e comunicabile del mio mondo interiore. Ogni parola, con i suoi colori e la sua consistenza è per me un'opera d'arte. Quando penso o parlo in manti è come se dipingessi con le parole. [Da Nato in giorno azzurro, Daniel Tammet]
La lingua schizofrenica
[...]Infatti scrivevo in "lingua" cioè, nel mio linguaggio segreto, usando espressioni e parole che sorgevano improvvisamente in me o che io stessa costruivo; poiché non mi sarei mai sentita in diritto di scrivere con parole vere. In questo caso la Regina avrebbe avuto il diritto di punirmi, poiché le lamentele che le indirizzavo erano accusatrici e ostili. Quando scrivevo in "lingua" mi indirizzavo alla vera Mamma, alla Mamma delle mele che amavo e che mi amava. Ma la vera mamma non poteva comprendere, poiché la Regina onnipotente e temibile l'aveva completamente sostituita. [...] Ebbi ancora crisi di colpevolezza; in quei momenti il mio dolore morale era infinito e piangevo per ore gridando "Raite, raite, raite, was habe ich gemacht?". Esprimevo spesso le mie lamentele in "lingua", usavo cioè parole incomprensibili, di cui alcune si ripetevano continuamente, come: "ichtiou, gao, itivarè gibastou, Ovèdè, ecc.". Non mi sforzavo ad inventarle; venivano spontaneamente e non significavano nulla per conto loro; erano il tono, il ritmo e la pronuncia che possedevano un senso. Mi lamentavo con queste parole esprimendo il profondo dolore e l'infinita desolazione che avevo in cuore. Non usavo le parole abituali poiché il mio dolore e la mia desolazione non avevano un oggetto reale. [Da Diario di una schizofrenica, Marguerite A. Sechehaye]
martedì 13 marzo 2012
come il gioco
dell'aquilone,
ha un senso solo se
ci si gioca
a distanza di spago,
se l'azzardo lo tira
troppo vicino a se,
l'amato perde
la forza di levità
che lo rende mistico.
Riccardo
Ricordo
lunedì 12 marzo 2012
"Solitudine"
Essere l'unica stella
visibile nello spazio nero.
Coccolata dal silenzio
e da pensieri rumorosi,
che fanno eco.
Essere la stella di qualcuno,
che si ama e si desidera,
ma da lontano
e in tacito silenzio.
- Amedeo 'Vincent' Di Luna -
domenica 11 marzo 2012
"Pulp" di Charles Bukowski... storia di pallottole, donne fatali e nostalgia...
Charles l'ubriacone, il beone da taverna, il genio, l'alcolizzato, il pittore di una fetta di società rattrappita e accartocciata - esattamente come lo era lui - a un angolo di una strada. Meglio conosciuto come Hank, detto anche Gambe da elefante. A metà strada tra un genio e un fallito. Il vecchio Bukowski ha finalmente ritrovato la strada di casa, messo a tacere i suoi demoni, le insicurezze trascinate dietro - come lo strascico di un vecchio vestito malmesso - per tutta la vita. Uno di quegli scrittori che non ha fatto altro che parlare di sé. E quale errore più grande, per uno scrittore, che mettere al centro dell'attenzione il proprio ego (in maniera esplicita si intende). E' come un uomo, che al suo primo appuntamento, non fa altro che parlare di sé stesso. Diventa noioso, appare come uno nevrotico che sente il bisogno di esternarsi, di risolvere i propri conti con i conflitti inconsci ansiogeni del suo io. Eppure lui piaceva - seppure il successo sia giunto in età avanzata - la gente comune, i poveri diavoli ci si rispecchiavano. Non vedevano dinanzi a sé un artista distante, un intellettuale pomposo e arrogante, un letterato rinchiuso nella sua erudita gabbia di cultura che di solito viene negata alla maggior parte della gente comune. Ma un eroico perdente, un uomo fidato, con cui poter scambiare quattro chiacchiere davanti a un boccale di birra, l'intellettuale dei derelitti e degli incompresi di tutto il mondo. Certo, sempre se non gli saltava la mosca al naso, per decidere di punto in bianco di mandarvi a fare in culo. O addirittura di prendervi a botte sul retro di un locale di infimo ordine. Come un vero boxeur, un combattente della strada, come il vecchio Hemingway, il più duro dei duri tra i letterati. Sempre pronto a combattere, ad afferrare la vita con i denti per farla sanguinare, per non essere "come tutti gli altri", per cercare di vivere la vita ogni giorno, per sentirla ruggire dentro, per ingannare la morte nel miglior modo possibile, per non lasciarsi anestetizzare dalla "non vita". "Vorrei essere seppellito vicino all'ippodromo, per sentire la volata sulla dirittura d'arrivo"... colui che si è preso gioco della morte fino alla fine, perché l'unico modo per raggirarla, per trattarla da vera puttana, è quello di stuprarla con l'arma dell'ironia, di vivere la vita minuto per minuto, senza mezzi termini o mezze misure, per non rischiare di impazzire definitivamente.
Come suggeriva la più famosa opera di Quentin Tarantino, "Pulp Fiction", all'inizio del film, con la sua definizione da dizionario: Pulp/1. Un morbido, umido ammasso di materia senza forma.
2. Una rivista o un libro contenente un argomento scandaloso e
generalmente stampato su carta ordinaria.
Nick Belane, "l'investigatore privato più dritto di Los Angeles", figlio di tutti i Sam Spade e i Philip Marlowe, gli uomini "dal whisky facile" (a voler scomodare Fred Buscaglione) e la pistola sempre alla mano, (solo che le creature di Hammet e Chandler, al contrario di quella di Bukowski, si prendevano decisamente troppo troppo sul serio), è il protagonista di questo romanzo. Per cui, come è facile immaginare, si troverà a intraprendere e a risolvere casi assurdi, al limite dell'allucinatorio (soprattutto se a guidare la storia è la penna di Bukowski), tra donne fatali, alieni e mariti infedeli. Ma la vera protagonista del romanzo è la morte, (un macabro preambolo, visto che l'autore morirà pochi mesi dopo il completamento dell'opera) che qui compare sotto forma di affascinante donna dalle forme prorompenti e straripanti, la quale chiederà al vecchio Belane ( alter ego dell'alter ego di tutte le storie di Bukowski: Henry Chinaski), di ritrovare il vecchio poeta, ormai morto, Louise-Ferdinand Céline, che, quasi come uno zombie letterario, sembra essere ancora in giro vivo e vegeto. E poi il tragico epilogo, che, considerata l'imminente morte dell'autore da lì a pochi mesi, ci dà quasi da pensare che tra Bukowki e la morte sia da sempre intercorsa un'intesa, un accordo segreto, una sorta di patto Faustiano.
"Pulp" è un affascinante riscoperta di un genere di altri tempi, dove l'ironia e la sgangherata visione di una vita portata oltre ai limiti, tipica della poetica Bukoskiana, di sicuro non mancano, ma è anche il testamento letterario di un grande autore, forse poco apprezzato dalla critica accademica, ma che di sicuro ha saputo donare speranza, e forse anche qualche sorriso, a chi una speranza e un sorriso, nella vita, non li ha mai ricevuti.
- Amedeo 'Vincent' Di Luna -
sabato 10 marzo 2012
Il contingente
In un millennio che si è aperto ostentando dittature, genocidi, stermini e terrorismi, c’è ancora posto per la politica? Definire la politica “arte del possibile” è un modo per giustificare un operare, sempre a fin di bene, appellandosi a uno stato di necessità.
La necessità della politica è postulata come aiuto a tutte le necessità risolutive, e quindi anzitutto alla necessità della morte, che da Aristotele non cessa di essere il male ultimo e necessario degli umani, la soluzione di tutto. Così, la necessità della politica risulta la necessità stessa della morte, la necessità della fine, che si formula come necessità infinita della fine della politica, come promette ogni buon politico che si rispetti, cioè ogni antipolitico, che riempia il parlamento o le piazze, le cellule o le celle. La fine della politica in nome del politicamente corretto, ovvero della tutela dei particolarismi individuali e collettivi, è scandita dalla regressione democratica di cui parla Alain-Gérard Slama in questo numero. La regressione democratica è in nome della necessità della politica che insegue il bene comune.
La politica non necessaria è la politica senza l’idea di morte. Questa politica non ha più bisogno della paura. Armando Verdiglione dedica un capitolo alla paura. La paura cui gli umani si accodano nasce dall’idea della necessità politica della morte. Per la necessità politica della morte gli umani muoiono di paura. La necessità politica della relazione sociale comporta l’orrore, quella dell’eliminazione dell’oggetto il terrore, quella dell’espunzione dell’Altro il panico e quella della coniugabilità dell’odio lo spavento. E la politica si propone come necessaria per salvare gli umani da questi contropiedi e contrappassi che lei stessa fomenta.
Le teorie illuministiche che hanno razionalizzato le mitologie aristoteliche sembrano trionfare nel pianeta. In cambio del bene promesso per tutti, ciascuno dovrebbe delegare la libertà, la sovranità, l’indipendenza, fino a temere la speranza, l’avvenire, il sogno stesso, come scrive nel suo testo Harry Wu. Questa necessità della politica che imperversa nel pianeta s’incarna ancora nei laogai cinesi e nelle carceri cubane, come testimonia Armando Valladares. Si prefigura nell’islamismo politico, che risulta, nelle testimonianze di Hamid Sadr, Ahmed Rafat e Bat Ye’Or, un grave pericolo contro Israele e l’Occidente. È ritornata nell’oligarchia della Russia di Putin che minaccia il pianeta e elimina il dissenso. È avallata dalle burocrazie del Parlamento europeo e dal terzomondismo dell’ONU. Non si tratta di scontri di religioni o di civiltà, bensì dell’utilizzo delle massime delle religioni e delle esigenze della civiltà a fini politici, a dimostrare che la politica ha i suoi fini che giustificherebbero i mezzi, idea a torto attribuita a Machiavelli.
Questa negazione della politica che è la politica presente, rappresentata da qualcuno, ha i suoi fini, che sono il controllo e la gestione sia dell’individuo e della sua irriducibilità, sia dell’Altro e della sua ragione. Cioè la loro eliminazione, proprio perché incontrollabili e ingestibili. L’irriducibilità dell’individuo è la giustizia, e la ragione dell’Altro trae con sé il diritto. E l’intoglibilità dell’individuo e dell’Altro esigono un’altra politica, non presente, non necessaria: la politica del tempo, dell’Altro, dell’ospite. Un ospite che non aspetta partecipazione, condivisione, amore, ma una politica del taglio non spaziale, della divisione che non fraziona, dell’odio che non parteggia. Politica che si qualifica nel contingente e non nella necessità ideale, proprio perché è temporale, non relazionale e non sociale. È secondo l’occorrenza, non secondo la possibilità, per questo esige la differenza e la varietà, non l’indifferenza e la variabilità, in cui occorre che tutto cambi perché tutto resti uguale.
Il contingente in cui esiste quest’altra politica, la politica del tempo, del fare nella parola, non è aristotelico, non partecipa cioè al quadrato logico delle modalità che inscrive in una proporzione il possibile, l’impossibile, il necessario e il contingente. Il contingente in cui si staglia il tempo non entra nei contrari e nei contraddittori, procede dalla contraddizione originaria, esige la funzione di Altro che non si relativizza e non si dialetticizza, salvo essere escluso, per essere rappresentabile negli altri, nei diversi. Contingente significa che qualcosa avviene e qualcosa diviene, scrive Armando Verdiglione. Contingente: l’avvenire e il divenire sono istanze temporali, non relazionali. Contingente: non il tempo della politica ma la politica del tempo, non il tempo della città, ma la città del tempo, del fare, dell’Altro, dell’ospite, dell’odio intransitivo e inconiugabile. Senza l’apertura e senza l’ospite, la politica fa senz’Altro: di qui la sua necessità finalistica, di qui la sua intolleranza. Ma anche la sua fine, con lo sterminio che ne consegue.
Da molte parti si teme che la politica abbia abdicato alla finanza globalizzata, e effettivamente la politica del tempo è essenziale perché la finanza non spadroneggi nel pianeta. Ma non perché la politica debba opporre alla finanza l’economia, che si farebbe economia politica, il principio della ragione sufficiente, del minimo male necessario. È il contingente, non il sufficiente, a impedire che la finanza si mentalizzi, si algebrizzi, si universalizzi. Solo se la politica è intoglibile, il dispositivo finanziario conclude alla scrittura, non alla fine. E l’impresa, con il suo rischio e la sua scommessa, offre una base pragmatica imprescindibile alla politica, come indicano gli interventi al Forum internazionale La politica dell’impresa, tenutosi nella sede di Confindustria Modena (14 marzo 2008) e pubblicati in questo numero.
Il governo della finanza senza la politica del tempo è il governo ideale. Che la fine regni sulle cose, che le cose siano finite risulta indispensabile per Aristotele perché possano essere pensate, padroneggiate, governate. Un governo sulle cose, sul tempo, sulla città è un governo perfetto, un governo necropolitano. Per questo Armando Verdiglione scrive che “quello che il discorso occidentale definisce il buon governo è il governo delle Parche”.
Ma, già con Niccolò Machiavelli, la politica non mira al governo sul tempo, sull’Altro, sulla città: “di cosa nasce cosa, e il tempo la governa”. Parla di governo del tempo, non sul tempo, dunque di governo della città, non sulla città. Come il tempo cifra, come la città si rivolge alla cifra: ecco il governo che non ha bisogno della paura.
Sergio Dalla Val
giovedì 8 marzo 2012
INDIA, l'ossesione della rappresentazione.
L'INDUISMO.
Il vibrato, tradotto dal latino con folgorare, dell’armonia tra i partiti e le religioni, strazia l’atto del silenzio. Ecco che chi rappresenta il silenzio, si trova spaesato perché infinito.
Francis
domenica 4 marzo 2012
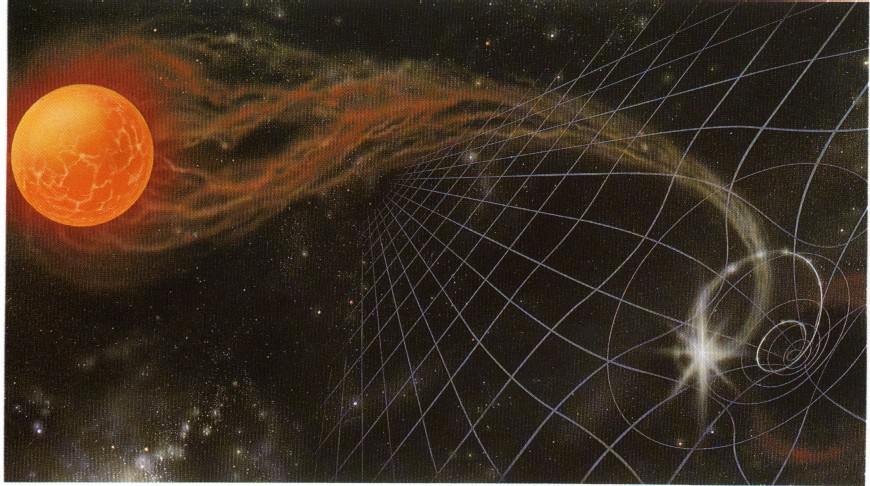
labirinto delle cause e degli effetti
per la diversità delle creature
che compongono questo universo singolare,
per la ragione, che non cesserà di sognare
un qualche disegno del labirinto,
per il viso di Elena e la perseveranza di Ulisse,
per l’amore, che ci fa vedere gli altri
come li vede la divinità,
per il saldo diamante e l’acqua sciolta
per l’algebra, palazzo di precisi cristalli,
per le mistiche monete di Angelus Silesius,
per Schopenhauer,
che forse decifrò l’universo,
per lo splendore del fuoco
che nessun essere umano può guardare
senza uno stupore antico
per il mogano, il sandalo e il cedro,
per il pane e il sale,
per il mistero della rosa
che prodiga colore e non lo vede,
per certe vigilie e giorni del 1955,
per i duri mandriani che nella pianura
aizzano le bestie e l’alba,
per il mattino a Montevideo,
per l’arte dell’amicizia,
per l’ultima giornata di Socrate,
per le parole che in un crepuscolo furono dette
da una croce all’altra,
per quel sogno dell’Islam che abbracciò
mille notti e una notte,
per quell’altro sogno dell’inferno,
della torre del fuoco che purifica,
e delle sfere gloriose,
per Swedenborg,
che conversava con gli angeli per le strade di Londra,
per i fiumi segreti e immemorabili
che convergono in me,
per la lingua che secoli fa parlai nella Northumbria,
per la spada e l’arpa dei sassoni,
per il mare, che è un deserto risplendente
e una cifra di cose che non sappiamo,
per la musica verbale d’Inghilterra,
per la musica verbale della Germania,
per l’oro che sfolgora nei versi,
per l’epico inverno
per il nome di un libro che non ho letto,
per Verlaine, innocente come gli uccelli,
per il prisma di cristallo e il peso d’ottone,
per le strisce della tigre,
per le alte torri di San Francisco e di Manhattan,
per il mattino nel Texas,
per quel sivigliano che stese l’Epistola Morale,
e il cui nome, come preferiva, ignoriamo,
per Seneca e Lucano, di Cordova,
che prima dello spagnolo
scrissero tutta la letteratura spagnola,
per il geometrico e bizzarro gioco degli scacchi,
per la tartaruga di Zenone e la mappa di Royce,
per l’odore medicinale degli eucalipti,
per il linguaggio, che può simulare la sapienza,
per l’oblio, che annulla o modifica i passati,
per la consuetudine,
che ci ripete e ci conferma come uno specchio,
per il mattino, che ci procura l’illusione di un principio,
per la notte, le sue tenebre e la sua astronomia,
per il coraggio e la felicità degli altri,
per la patria, sentita nei gelsomini
o in una vecchia spada,
per Whitman e Francesco d’Assisi che scrissero già
questa poesia,
per il fatto che questa poesia è inesauribile
e si confonde con la somma delle creature
e non arriverà mai all’ultimo verso
e cambia secondo gli uomini,
per Frances Haslam, che chiese perdono ai suoi figli
perché moriva così lentamente,
per i minuti che precedono il sonno,
per il sonno e la morte,
quei due tesori occulti,
per gli intimi doni che non elenco,
per questa musica, misteriosa forma del tempo.
Jorge Luis Borges.
sabato 3 marzo 2012
Alfabeto, parole.
Il capitolo, il libro possente
Poi la rivelazione terminò.
Ma negli occhi dell'altro
Ciascuno contemplava l'ignoranza
Divina, ancora più che nell'infanzia:
L'uno all'altro, fanciulli.
Tentammo di spiegare
Quanto era per entrambi incomprensibile.
Ahi, com'è vasta la saggezza
E molteplice il vero! Emily Dickinson


